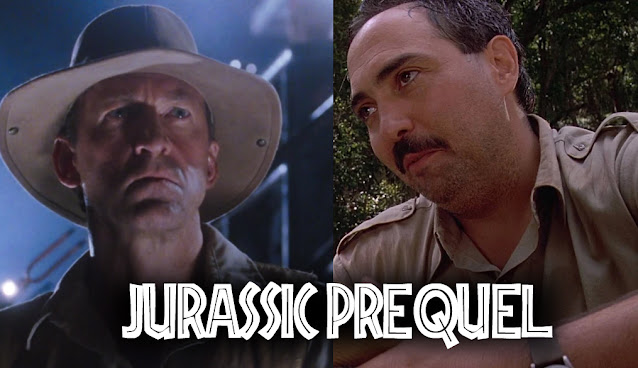|
| Mascellare di giovane Allosaurus (da Malafaia et al. 2025). La linea rossa in A indica il livello delle gengive deducibile dal pattern di erosione dello smalto. |
I lettori abituali del blog conoscono la premura che ho sempre dedicato nel diffondere la consapevolezza che la tafonomia sia la spina dorsale della paleontologia, e che nulla in paleontologia abbia senso se non è fondato sull'analisi tafonomica. Sovente, ciò che noi osserviamo in un fossile è comprensibile solamente dopo che abbiamo decifrato il contesto nel quale esso (il fossile, non l'organismo originario) si è formato: tale decifrazione è proprio il lavoro della tafonomia. Inoltre, particolari condizioni di preservazione (svelate dalla tafonomia) ci aiutano a spiegare particolari altrimenti enigmatici, spiegazione che, a sua volta, può portare a conclusioni inaspettate su altri elementi della biologia estinta che non avremmo potuto ricavare da fossili preservati in condizioni differenti.
Malafaia et al. (2025) hanno analizzato la tafonomia di un piccolo esemplare di mascellare dal Giurassico Superiore del Portogallo, originariamente descritto nel 2005 da Rauhut e Fechner, e riferibile ad Allosaurus. Si tratta di uno degli esemplari più piccoli ed immaturi riferibili a questo taxon.
L'analisi tafonomica dell'esemplare ha evidenziato una particolare erosione della superficie esterna del mascellare, ed in particolare la completa mancanza dello smalto nella punta delle corone dei denti, che ha esposto la dentina sottostante: nel resto della corona, lo smalto è invece preservato. Quale processo fisico o chimico può produrre una tale conservazione? Perché lo smalto è assente sulla punta dei denti ma non nel resto della corona, nonostante sia formata dalla medesima combinazione di smalto e dentina?
Gli autori dimostrano che tale pattern di erosione dei denti non è dovuto a processi geologici, né a particolari condizioni di acidità del terreno, né è dovuta all'azione delle piante. Il solo processo in grado di produrre tale decalcificazione parziale dei denti è l'azione dei succhi gastrici. Pertanto, il piccolo mascellare di Allosaurus fu parzialmente digerito prima di fossilizzare. La digestione parziale suggerisce che il predatore abbia rigurgitato il mascellare, forse in modo analogo a quanto osserviamo oggi in vari mammiferi, pesci ed uccelli carnivori che rigurgitano le parti non edibili delle loro prede.
Gli autori mostrano che la dissoluzione della corona dello smalto dei denti è frequente nei resti rigurgitati di lucertole (Smith et al. 2021), e che questa è legata al grado di esposizione dei denti nella bocca. Per comprendere questo meccanismo occorre distinguere tra due agenti digestivi presenti nel succo gastrico: l'acido cloridrico e gli enzimi digestivi. L'acido cloridrico è più rapido nell'azione rispetto agli enzimi digestivi, e colpisce principalmente la parte inorganica, quindi la superficie dei denti. Gli enzimi digestivi invece attaccano la parte organica della preda, come tessuti molli (pelle, muscoli, ecc...), ma più lentamente. Quando una mandibola di lucertola viene ingerita da un predatore, l'acido cloridrico inizia subito a consumare la parte esposta dei denti, mentre agisce più lentamente sulla parte organica, contro la quale lavorano più lentamente gli enzimi. Quando questi resti vengono rigurgitati, la digestione è stata solo parziale, e non ha ancora iniziato ad attaccare la parte organica. Di conseguenza, solamente la punta dei denti è stata erosa al punto da esporre la dentina sottostante lo smalto. Cosa ha protetto il resto dei denti? La gengiva carnosa, la quale, essendo di natura organica, non è stata a sufficienza nello stomaco per essere pienamente attaccata dai lenti enzimi digestivi.
Pertanto, la preservazione particolare dei denti del piccolo mascellare di Allosaurus si spiega unicamente assumendo che in vita l'animale avesse delle spesse gengive simili a quelle delle lucertole, le quali avvolgevano la metà basale della corona dei denti, facendo esporre solamente la punta dei denti. Questo implica che Allosaurus avesse una bocca più simile a quella delle lucertole (con spesse gengive a protezione dei denti) e non come nei coccodrilli, nei quali gran parte della corona del dente è esposta. Si tratta quindi di un ulteriore sostegno all'ipotesi che i dinosauri predatori avessero un tegumento periorale più simile a quello dei lepidosauri (con labbra, spesse gengive e importante lubrificazione del cavo orale) che a quello dei coccodrilli moderni (privo di labbra e più estesamente corneificato).
Bibliografia:
Malafaia, E., Maggia, B., Rauhut, O. 2025. Taphonomic insights from a corroded maxilla of a hatchling Allosaurus from the Upper Jurassic of Guimarota (Portugal). Abstracts Book X Jornadas Internacionales sobre Paleontología de Dinosaurios y su Entorno. 4-6 septiembre. Salas de los IInfantes. Burgos, España. 143-146.
Rauhut, O. W. M., Fechner, R. (2005): Early development of the facial region in a non-avian theropod dinosaur. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 272, 1179-1183.
Smith, K. T., Comay, O., Maul, L., Wegmüller, F., Le Tensorer, J.-M., Dayan, T. (2021): A model of digestive tooth corrosion in lizards: experimental tests and taphonomic implications. Scientific Reports, 11(1), 12877.